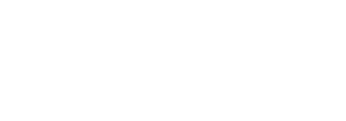Aggiornamenti
NOTIZIE E SENTENZE
La Corte d'appello di Firenze individua i criteri per distinguere tra gli emolumenti di natura retributiva e quelli di natura risarcitoria
L’individuazione dei criteri distintivi tra la natura retributiva e quella risarcitoria degli emolumenti spettanti alle lavoratrici e i lavoratori alle dipendenze di una datrice italiana e dislocati all’estero impone il confronto con una materia giuridica di difficile mappatura, seppure centrale al computo di preminenti competenze retributive, come la base imponibile del trattamento di fine rapporto (TFR). La recente Corte d’Appello di Firenze dell 14 gennaio 2025, in un contraddittorio patrocinato dallo studio Legalilavoro di Firenze, fa il punto dei profili di problematicità che la questione solleva e offre dei principi d’orientamento in un contesto tuttora privo di una giurisprudenza chiara e univoca.
Le ragioni di tale complessità sono da ricondurre dapprincipio alla formulazione generale ed elencatoria prevista all’art. 2120 c.c. disciplinante il TFR. La disposizione fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione ai fini del calcolo del TFR, limitandosi ad escludere dal computo i soli emolumenti corrisposti a titolo occasionale e di rimborso spese, oltre alle eventuali eccezioni previste dalla contrattazione collettiva. In tal modo, la norma sostanzialmente devolve alla giurisprudenza il compito di dirimere la qualificazione retributiva e/o risarcitoria del trattamento economico. Beninteso, il discernimento giurisprudenziale si complica al confronto con il trattamento economico estero, in virtù delle innumerevoli voci economiche aggiuntive che questa solitamente contempla e l’altrettanto frequente mancanza di definizioni convenzionali per ciascuna di esse. Il caso di specie versa in una situazione simile. Senza entrare nel merito delle singole voci contese, proviamo a ritracciare l’orientamento di massima del Collegio.
Il principio cardine per la qualificazione retributiva di una voce economica è rappresentato dal suo collegamento sinallagmatico, tanto genetico quanto funzionale, con la prestazione lavorativa. In altre parole, rientrano nella nozione di retribuzione tutte le utilità che costituiscano un corrispettivo per l’attività di lavoro svolta. In questo senso, la valutazione della natura degli emolumenti deve fondarsi su un esame del concreto svolgimento del rapporto e della funzione effettiva delle somme corrisposte. Dalla centralità del sinallagma e dalla rilevanza pertanto acquisita dalla considerazione della concreta attuazione del rapporto di lavoro, discendono una serie di osservazioni utili a orientare la qualificazione delle singole voci economiche.
Prima di tutto, e riprendendo la disposizione generale dell’art. 2120 cc, anche le eventuali norme collettive volte ad escludere alcune voci economiche dall’onnicomprensività del trattamento retributivo devono sottostare alla realtà del rapporto di lavoro posto in essere, gravando sulla parte che le invoca l’onere di provare la loro negazione in concreto. Lo stesso vale per tutte quelle somme erogate e riconosciute nominalmente come rimborsi spese. A rigor di logica, quindi, «alle somme erogate a titolo di rimborso spese viene riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pure indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa», non assumendo rilievo neppure «il carattere forfettario o meno del rimborso, ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all'estero» (Cass. 18 marzo 2009, n. 6563).
Volendo riassumere l’orientamento di massima in una concisa formulazione, «il trattamento estero ha natura retributiva, tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui sia correlato alle qualità e condizioni personali concorrenti a formare la professionalità indispensabile per prestare lavoro fuori dai confini nazionali». Diversamente, hanno natura riparatoria di rimborso spese, le erogazioni di somme che «costituiscano reintegrazione di una diminuzione patrimoniale derivante da una spesa effettiva sopportata dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore, […] restando normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) è fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva» (in questo senso, più volte, la giurisprudenza di legittimità: Cass. 30 dicembre 2022, n.38168; Cass. 22 luglio 2016, n. 15217; Cass. 27 luglio 2018, n.20011).
Sulla base di questo quadro e raccogliendo gli indici di una ricca giurisprudenza, la corte fiorentina raccoglie tra le elementi sintomatici e indiziari della genesi e funzione retributiva: «a) continuità, periodicità e obbligatorietà della somma; b) pagamento anche in assenza di giustificativi di spesa; c) natura compensativa del disagio o penosità della prestazione; d) rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione; e) garanzia di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro; f) eventuale prelievo contributivo effettuato [seppur venga evidenziato come quest'ultimo indice non risulti essere decisivo».
a cura di Michela Biscosi
Legalilavoro Firenze
(A. Firenze 14 gennaio 2025)
Parole chiave: Retribuzioni